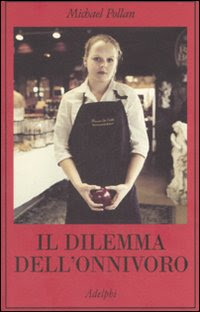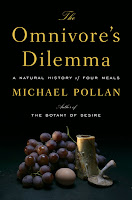“
Ciò che un americano trova nel piatto a cena ha percorso in media duemilaquattrocento chilometri prima di arrivare lì: spesso il cibo ha più esperienza del mondo di quanta non ne abbia il suo consumatore”.
“
Il dilemma dell’onnivoro” di
Michael Pollan esplora la catena alimentare di quattro pasti, come è indicato nel sottotitolo originale, A natural history of four meals: la catena industriale, quella biologica-industriale, quella del cibo proveniente da una fattoria, fuori dagli schemi “bio” che esprimono spesso una logica di marketing più che una filosofia di vita e infine una cena ottenuta coltivando, raccogliendo e cacciando il cibo (la catena alimentare più breve, sebbene quella più faticosa).
Gli onnivori si trovano di fronte a un dilemma (l’espressione è mutuata dallo studioso Paul Rozin che l’ha introdotta nel 1976). L’onnivoro grazie alla sua capacità di ottenere energie dalle fonti più disparate può colonizzare tutti gli habitat, ma si è trovato durante la sua evoluzione di fronte al problema di ciò che era buono da mangiare oppure non lo era. La capacità di comunicare ha ridotto la portata di questo dilemma, ma la sua complessità è stata per alcuni antropologi una delle cause che ha richiesto circuiti cerebrali più evoluti.
Nella prima parte Pollan esamina la catena alimentare industriale.
“L’industria dei fertilizzanti è sorta dagli sforzi di riconvertire la macchina bellica in tempi di pace”: fertilizzanti e pesticidi sono i figli dei gas tossici e degli esplosivi sviluppati ed usati fin dalla guerra nel Vietnam.
Già alla fine della seconda guerra mondiale il governo americano si ritrovò con enormi quantità di nitrato di ammonio, che è alla base dell’industria degli esplosivi, ma che è anche un ottimo fertilizzante, una fonte di azoto pronta per le piante commestibili, che da ora potranno essere coltivate in maniera intensiva. E’ interessante notare come i fertilizzanti ritornino alla loro “esplosiva” natura negli attentati dei movimenti neonazisti americani (una buona dose di fertilizzanti fu impiegata nell’attentato del 1995 contro l’edificio federale Alfred P. Murrah ad Oklahoma City
[1]).
Il primo e decisivo contributo della chimica organica alla distruzione dell’equilibrio naturale fu data nel 1840 da von Liebig, ma un passo fondamentale fu quello compiuto da Fritz Haber che ricevette il Nobel nel 1920 “per aver migliorato gli standard dell’agricoltura e il benessere dell’umanità”. La capacità di fissare l’azoto atmosferico nel mondo naturale è, come noto, limitata, ma grazie al processo Haber-Bosch è possibile ottenere composti azotati di sintesi. Haber fu anche l’inventore del gas Zyclon-B. Come diceva ironicamente DeLillo: “una vita migliore attraverso la chimica”…
Sicuramente grazie all’arricchimento sintetico del suolo si è riusciti a produrre molto più cibo e, secondo alcune stime, “due abitanti del pianeta su cinque non sarebbero vivi oggi senza il processo Haber-Bosch”. Come sempre è la gestione della conoscenza che determina i risultati visibili, la conoscenza in sé invece possiede un valore positivo. (E non lo dico solo perché anch’io ho pubblicato su una rivista che si chiama
Current Nutrition and Food Science che appartiene alla categorie di riviste che l’autore stigmatizza. La chimica è una scienza affascinante).
Nella sua analisi dell’industria alimentare Pollan si scontra con la verità che sta alla base dell’intero processo: il mais (la monocoltura che ha radicalmente trasformato il paesaggio del Midwest americano) si trova praticamente ovunque: “un supermercato americano ha in vendita quarantacinquemila prodotti; più di un quarto di questi contiene mais, ivi inclusi articoli non alimentari”. E l’uomo? L’uomo ormai è “una pannocchia con le gambe”.
Nell’allevamento intensivo moderno viene usato il mais come elemento principale della dieta dei bovini, che per loro natura sarebbero degli erbivori; ricordate un’immagine di una mandria di bovini su un pascolo? Bene, dimenticatela. Oggi si è riusciti a convertire un ruminante in una macchina che trasforma mais in carne, ovviamente sono animali più esposti alle malattie, ma non c’è problema: l’industria farmaceutica sosterrà queste macchine fino al momento di macellarle grazie ai suoi potenti antibiotici ad ampio spettro.
“Il granturco ha il vantaggio di essere una fonte calorica concentrata che fa ingrassare le bestie in fretta e rende la loro carne marezzata al punto giusto, dotata di quel gusto e quella consistenza che i consumatori americani si sono abituati a gradire. Eppure è certo che queste bistecche di manzo tirato su a granturco (corn-fed) sono peggio per la nostra salute, perché contengono più acidi grassi insaturi e meno omega-3 rispetto a quelle di animali che si sono nutriti di erba”.
Va sottolineato che l’industria alimentare brucia un quinto del petrolio consumato negli Stati Uniti (ovvero quasi quanto tutte le automobili del paese). Questo si traduce nella devastante constatazione che sono necessarie “dalle sette alle dieci calorie di combustibile fossile per produrre ogni singola caloria che finisce sulle tavole americane”.
Michael Pollan si sposta nella parte centrale del suo saggio ad analizzare la catena alimentare biologica. Il movimento biologico nacque dalle idee di filosofi ed agronomi rivitalizzate dal movimento culturale nato alla fine degli anni sessanta. Il risultato sono un mucchio di dollari. Infatti i pionieri del settore siedono su comode poltrone all’interno del consiglio di amministrazione di aziende dal fatturato in stabile crescita. Come molti altri ex rivoluzionari in erba degli anni della contestazione hanno capito da tempo, anche per i signori del biologico “è il mercato che decide”.
E se abdichiamo dalle nostre scelte morali o riusciamo a convincerci che in fondo stiamo comunque facendo meno danni di quelli provocati attraverso l’industria alimentare standard, il mercato biologico offre un’alternativa valida. Catene di negozi come Whole Foods procurano al cliente un’esperienza culturale, che l’autore definisce “Arcadia da supermercato”. Opuscoli con verdi pascoli e fattorie, aie dove le galline razzolano libere. Ma sarà davvero così?
Indovinate.
Per essere certificato come biologico un allevamento di galline o polli deve fornire uno spazio minimo agli animali e garantire un accesso all’aperto e fornire agli animali un’alimentazione vegetale priva di pesticidi. In conclusione, Pollan entra in un capannone dove ondeggia un mare bianco di piume, migliaia e migliaia di galline, munito di una piccola porta che conduce all’esterno: peccato che le galline siano troppo timorose per avventurarsi oltre quell’apertura ed in pratica vivano sempre confinate nel loro spazio microscopico dove un sistema di pompe e canaline permette di ingozzarle di mangime ed acqua. Il biologico è servito.
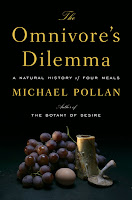
“All’inizio alcuni agricoltori riuscirono in modo ammirevole a creare nuove catene alimentari nelle loro fattorie. I guai iniziarono quando questi si scontrarono con le pretese dei supermercati. Così come è accaduto in molti altri ambiti la logica naturale non ha resistito alla forza di quella industriale in cui si dà per assunto di base che una fonte di energia a buon mercato sarà sempre disponibile” L’industria alimentare biologica si trova perciò in una posizione alquanto scomoda: “galleggia su un mare di petrolio che si fa sempre meno profondo”.
Michael Pollan è un ottimo scrittore ed alterna vivide descrizioni a riflessioni altrettanto incisive. Oltrepassata la metà del libro, entriamo in un mondo diverso, dove la catena alimentare si fa più breve. Pollan descrive una settimana passata a lavorare presso la Polyface, una fattoria della Virginia. Joel Salatin gestisce la sua azienda alternando colture diverse sui campi e spostando frequentemente gli animali, ovvero bovini, maiali, e polli e galline. Tutti si nutrono pascolando sui prati. L’erba converte l’energia solare in calorie. L’impiego di combustibili fossili è limitato all’indispensabile. Tutti i prodotti della fattoria sono venduti in un raggio di centocinquanta o duecento chilometri. Gli acquirenti sono ristoranti, consumatori individuali che si recano alla fattoria o gruppi di acquisto (un fenomeno che si sta diffondendo anche in Italia, un gruppo di persone che sceglie di fare degli acquisti congiunti per spendere meno ed avere una migliore qualità). Il risultato di questa esperienza è una cena consumata con amici dove tutto ha un sapore migliore, in fondo quello che è buono per il gusto e la mente, è buono anche per il nostro corpo: una verità che risponde al dilemma dell’onnivoro ovvero “cosa è buono da mangiare?”
Nell’ultima parte del libro Pollan affronta la catena alimentare più breve: quella del cacciatore, coltivatore e raccoglitore. Naturalmente l’autore, che nella fattoria di Joel Salatin ha partecipato all’uccisione di alcuni polli, si pone il problema del vegetarianesimo. Pollan inizia a leggere “Liberazione animale” di Peter Singer al ristorante The Palm davanti a una costata al sangue: un’esperienza che non consiglierebbe a nessuno…
L’evoluzione ci ha portato a cibarci di numerose specie rese domestiche, che senza l’uomo non vivrebbero in natura, specie per cui gli animalisti in effetti non nutrono troppa simpatia. Per un animalista l’estinzione dei polli è preferibile alla loro esistenza come prigionieri in un campo di allevamento intensivo. Ma Michael Pollan è stato alla Polyface e sa che l’allevamento non significa necessariamente sofferenza.
Non si può dire lo stesso del mondo naturale: “se un orso mette le grinfie su una pecora che allatta, se la sbrana viva, cominciando dalle mammelle. No, in genere gli abitanti del bosco non muoiono senza sofferenze circondati dall’affetto dei loro cari”.
La nostra evoluzione ci ha resi ciò che siamo: “Dovremmo perlomeno riconoscere che il nostro desiderio di mangiare carne non è, come pensano gli animalisti, una semplice predilezione gastronomica. Con lo stesso ragionamento potremmo definire il sesso, che oggi non è più strettamente necessario alla riproduzione, solo una preferenza nel modo di divertirsi. No, essere carnivori è qualcosa di molto più profondo”.
Inoltre, nella catena alimentare che ha plasmato il mondo, l’allevamento, e non parlo di allevamento industriale, ha svolto un’azione fondamentale. E’ altamente improbabile riuscire a costruire un’agricoltura sostenibile senza la presenza di animali, che mettono in circolo sostanze nutritive e tengono in piedi la produzione locale. “Se ci preoccupiamo per la salute della natura, più della coerenza delle nostre scelte etiche e dello stato della nostra anima, mangiare carne potrebbe essere quanto di più morale possibile”.
L’ultimo pasto descritto da Pollan comprende prodotti provenienti dal suo orto, prodotti raccolti, ovvero alcuni funghi e delle ciliegie, e infine un maiale selvatico cacciato nei boschi.
La catena più breve e insieme quella più faticosa. Naturalmente la caccia è l’attività che suscita in Pollan i sentimenti più contrastanti e che lo spinge alle riflessioni più approfondite. Spaziando da Emerson a Ortega y Gasset ad Aldo Leopold gli argomenti si intrecciano e si rincorrono per molte pagine.
“Confesso che una parte di me invidia la saldezza morale del vegetariano, l’innocenza del mangiatore di tofu; eppure una parte di me ne provava compassione. L’utopia dell’innocenza dipende di solito dalla negazione del vero che è anche una forma di presunzione. Secondo Ortega è in un certo senso immorale non riuscire a guardare in faccia la realtà”.
La grande bellezza della scrittura di Michael Pollan è quella di riuscire ad elaborare dell'ottimo cibo per la mente con una sapore favoloso. Ed è ciò che ogni scrittore di saggistica in fondo dovrebbe fare. Genera idee, stimola il pensiero, ispira la creatività: “Il dilemma dell’onnivoro” è tra il miglior cibo per la mente che potete trovare in circolazione.
[1] Per l’interessante rapporto tra agricoltura e movimenti neonazisti o antigovernativi americani si veda l’eccezionale saggio di Joel Dyer “
Raccolti di rabbia” (Fazi, 2002).
 ere l’anno. Stupendo. Se non lo avete, cercate di rimediare quanto prima. Una meraviglia.
ere l’anno. Stupendo. Se non lo avete, cercate di rimediare quanto prima. Una meraviglia.



 Genna esplora pulsioni e fantasie. Finge di fingere. Non finge e questo significa che i fatti sono veri o che i fatti sono inventati.
Genna esplora pulsioni e fantasie. Finge di fingere. Non finge e questo significa che i fatti sono veri o che i fatti sono inventati.




















 “Nell’aria sottile che respirerete dopo l’undici settembre”
“Nell’aria sottile che respirerete dopo l’undici settembre”