
mercoledì 23 luglio 2008
domenica 20 luglio 2008
Il ragazzo delle consegne di Joe McGuinniss Jr. Less than zero, Las Vegas, 2008.

Molto nel romanzo ricorda “Meno di zero”. Siamo a Las Vegas e non a Los Angeles, ma la scrittura di McGinniss Jr. ha quel ritmo, tipico di Ellis, a metà tra il delirio e la visione più lucida che possiate immaginare.
Il deserto, un cartellone pubblicitario che incombe sulle strade ripetendo il suo slogan, il vento caldo, le prostitute consegnate a casa dei clienti, ragazzine che caricano video su MySpace e YouTube. “Il ragazzo delle consegne” ha situazioni e personaggi misteriosi e insieme semplici. Da questa materia prende forma un quadro desolante e vivo.
Chase ha il cranio distrutto, ricostruito dai chirurghi, ma il romanzo racconta essenzialmente tutto quello che è successo prima di arrivare alla situazione presentata nell’incipit. E’ Chase il ragazzo delle consegne, o meglio l’uomo, ormai infatti non è più uno studente, dipinge
 o vorrebbe ricominciare a farlo, ha insegnato arte in una scuola. Insieme a lui Bailey e Michelle. I flashback conducono lentamente a una verità che si presagisce da subito, ma in questa scrittura sospesa tutto è avvolto da un perenne senso di attesa. Il procedere per inerzia dei personaggi ha qualcosa di ipnotico. Nell’aria calda di Las Vegas, dove dalla finestra di un albergo giunge ad ondate il pulsare della Strip, il respiro sembra mancare.
o vorrebbe ricominciare a farlo, ha insegnato arte in una scuola. Insieme a lui Bailey e Michelle. I flashback conducono lentamente a una verità che si presagisce da subito, ma in questa scrittura sospesa tutto è avvolto da un perenne senso di attesa. Il procedere per inerzia dei personaggi ha qualcosa di ipnotico. Nell’aria calda di Las Vegas, dove dalla finestra di un albergo giunge ad ondate il pulsare della Strip, il respiro sembra mancare.Non è un romanzo grandioso, non ha certamente il fascino e la complessità della scrittura di Richard Powers, ma “Il ragazzo delle consegne” racchiude in ogni riga una verità dolorosa, ma ogni riga scorre via come a non voler lasciare traccia di sé: in questa sua ambivalenza, in questa pressione lieve e indecifrabile, è racchiusa la bellezza dell’opera.
giovedì 17 luglio 2008
Gli interessi in comune di Vanni Santoni

“Buone vacanze e non usate sostanze” (carabiniere incontrato a un posto di blocco vicino a Perugia, estate del 1994).
Il Valdarno è la provincia di una provincia: neppure Firenze mantiene le sue promesse. “In questa città le ultime iniziative decenti sono state quelle di Lorenzo il Magnifico”.
Nella vallata di paesi, agriturismi, bar e circoli arci, sopravvive un gruppo di ragazzi seguito dal 1995 al 2005, tra tutti Iacopo, il Malpa, Dimpe, il Mella e Paride. “Gli interessi in comune” di Vanni Santoni prende il titolo da un passaggio del libro che è una triste epifania: “una persona finita insieme a loro solo per un interesse in comune” che poi sarebbe la ricerca meticolosa del consumo di sostanze psicotrope varie. Di base le canne, neanche c’è da discutere, ovvio. Poi si alternano LSD, mescalina, MDMA, fenilciclidina, ketamina, cocaina, salvia divinorum, anfetamine e via di questo passo, astenendosi giusto dall’eroina endovena, che è da “robbosi”.
Probabilmente non avrei dovuto ridere, son cose serie, ma quando Iacopo e il Malpa vanno a trovare un amico ricoverato d’urgenza in ospedale e si preparano due flebo (Ringer) di morfina, non ho resistito. Non ho resistito neppure altrove, a dire il vero. Vanni Santoni, l’Irvine Welsh de Montevarchi, sdraia il lettore con i racconti di dieci anni di viaggi allucinati. I protagonisti crescono, in qualche modo finiranno l’università, e in qualche altro modo rientreranno nelle statistiche dell’Italia che produce reddito, beninteso, lo produce in gran parte per altri, in genere.
Il paesaggio è quello dei dintorni di Figline, anche se compare due volte Amsterdam e mi ricorda il viaggio della maturità e quello fatto dopo dieci anni quando finalmente ho visto il Van Gogh Museum, il Rijksmuseum, Delft, il Mauritshuis di Den Haag, i mulini a vento, e tutte le case storiche dello Herengracht. Ma tolti questi momenti nel “lunapark d’Europa”, la storia è lì in Valdarno con Firenze in cima. Nella provincia opprimente, ci sono paesi come Ambra “dove circola più droga che a Caracas”; e sono posti come il bar, il circolino che radunano gli psiconauti di Vanni Santoni.
Il progetto di Iacopo di scrivere un manifesto che racconti “noi” cioè loro, ovvero una generazione, naufraga subito. L’idea di Santoni non è il ritratto generazionale (lascia diversi indizi evidenti) e questo lo salva dalla facile caduta in cliché che di certo non gli appartengono.
L’uso delle sostanze è ben documentata: “ero deciso a venire, e ora sono ancora più deciso a sfasciarmi. Non siamo qui per divertirci”.
La trama è letteralmente tenuta insieme dalla sostanze, un collante alquanto solido perché effettivamente reale in una fascia della popolazione giovanile. Come detto questo non è un ritratto generazionale sebbene inizi con un manifesto. Quindi per quelli che aspettano cosa dice Ratzinger o il direttivo di partito per esprimere un’opinione, per quelli che hanno studiato e basta e hanno famiglia e sono stati sempre responsabili già a cinque anni, per quelli che il papà gli ha lasciato l’azienda e gli tocca il soverchiante peso di dare da mangiare (i vestiti sono a parte) a cento operai, per quelli che il lavoro è tutto e sono realizzati e la vita vale e bisogna darle un senso, per quelli che hanno già progettato matrimonio, figli e vacanze con anni di anticipo… be’ questo romanzo non è per voi, e neppure per me in effetti, però nell’asfittico universo letterario italiano, pur con i suoi difetti, “Gli interessi in comune “ di Vanni Santoni rimane un’opera sofferta e liberatoria insieme, un malinconico commiato verso gli anni che stanno alle vostre spalle, in qualsiasi modo abbiate deciso di trascorrerli.
martedì 15 luglio 2008
She and Him, Volume One
 Un album favoloso, un gioco, una gioia, musica acustica per l’estate ormai inoltrata. She & Him, ovvero Zooey Deschanel e M. Ward, si ispirano esplicitamente a Nina Simone, Chet Atkins, The Ronettes e le canzoni sono una perfetta sintesi di dolcezza e allegria, canzoni di quelle che ti stampano un sorriso sul volto. Zooey Deschanel, attrice in vari film (ora è la protagonista del biopic su Janis Joplin), si rivela un’ottima cantautrice, infatti
Un album favoloso, un gioco, una gioia, musica acustica per l’estate ormai inoltrata. She & Him, ovvero Zooey Deschanel e M. Ward, si ispirano esplicitamente a Nina Simone, Chet Atkins, The Ronettes e le canzoni sono una perfetta sintesi di dolcezza e allegria, canzoni di quelle che ti stampano un sorriso sul volto. Zooey Deschanel, attrice in vari film (ora è la protagonista del biopic su Janis Joplin), si rivela un’ottima cantautrice, infatti , escludendo un brano dei Beatles e il riarrangiamento di uno tradizionale, scrive tutti i testi e le musiche. “Volume One” nasce dai numerosi demo registrati da Deschanel, musica fatta in casa e poi portata in studio. Un album limpido, molto semplice che, per questo motivo, è più facile descrivere per sensazioni. Una serata in terrazza, il calore del giorno che evapora nell’ombra, il vento che muove le foglie. Una cosa così.
, escludendo un brano dei Beatles e il riarrangiamento di uno tradizionale, scrive tutti i testi e le musiche. “Volume One” nasce dai numerosi demo registrati da Deschanel, musica fatta in casa e poi portata in studio. Un album limpido, molto semplice che, per questo motivo, è più facile descrivere per sensazioni. Una serata in terrazza, il calore del giorno che evapora nell’ombra, il vento che muove le foglie. Una cosa così.
domenica 13 luglio 2008
Quello che ti meriti di Anne Holt

Gli elementi del romanzo “Quello che ti meriti” sono di una banalità disarmante.
1.Bambini rapiti, segregati e poi riconsegnati alle famiglie uccisi, ma non si sa in che modo (la soluzione naturalmente è semplice, ma i medici legali norvegesi non sono molto svegli, da come li dipinge la Holt).
2.Yngvar Stubø, commissario di polizia, e Johanne Vik, psicologa e avvocato: la solita tensione erotica trai due mentre tentano di risolvere il caso del punto 1 (non entusiasmatevi troppo le loro ginocchia si sfioreranno a pagina 267: se si vuole continuare a scrivere usando gli stessi personaggi è naturale tirarla per le lunghe, si sa che i lettori deficienti abbondano).
3.Il caso di un uomo condannato ingiustamente per l’omicidio di una bambina e rilasciato, senza spiegazioni, nel 1965 (qualcosa in questa vicenda messa di traverso per tutto il romanzo evoca il vago sospetto che il fatto si debba intrecciare con le indagini).
Già Patricia Cornwell non scrive molto bene, ma Anne Holt riesce a fare peggio. Costruisce con cura gli anelli di una collana molto solida: un romanzo per menti dotate di lobi frontali atrofizzati, e neppure l’area di Broca se la deve passare molto bene.
“Quello che ti meriti” entra a buon diritto nel novero dei libri insulsi che sarebbero dovuti rimanere nel cassetto o hard disk dell’autore/autrice; romanzi che solo un editore come Einaudi [1], capace, una volta raggiunto il fondo, di iniziare a scavare, può pubblicare con orgoglio. Il simbolo dell’editore, ovvero lo struzzo, ormai da anni ha infilato la testa sottoterra e i risultati sono romanzi mediocri come questo. Esattamente come dice il titolo: “Quello che ti meriti”… vedete voi se il monito è rivolto all’incauto lettore, al gruppo redazionale dell’Einaudi o ad entrambi. Da evitare.
venerdì 11 luglio 2008
Il dilemma dell'onnivoro di Michel Pollan
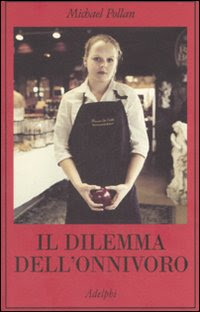
“Il dilemma dell’onnivoro” di Michael Pollan esplora la catena alimentare di quattro pasti, come è indicato nel sottotitolo originale, A natural history of four meals: la catena industriale, quella biologica-industriale, quella del cibo proveniente da una fattoria, fuori dagli schemi “bio” che esprimono spesso una logica di marketing più che una filosofia di vita e infine una cena ottenuta coltivando, raccogliendo e cacciando il cibo (la catena alimentare più breve, sebbene quella più faticosa).
Gli onnivori si trovano di fronte a un dilemma (l’espressione è mutuata dallo studioso Paul Rozin che l’ha introdotta nel 1976). L’onnivoro grazie alla sua capacità di ottenere energie dalle fonti più disparate può colonizzare tutti gli habitat, ma si è trovato durante la sua evoluzione di fronte al problema di ciò che era buono da mangiare oppure non lo era. La capacità di comunicare ha ridotto la portata di questo dilemma, ma la sua complessità è stata per alcuni antropologi una delle cause che ha richiesto circuiti cerebrali più evoluti.
Nella prima parte Pollan esamina la catena alimentare industriale.
“L’industria dei fertilizzanti è sorta dagli sforzi di riconvertire la macchina bellica in tempi di pace”: fertilizzanti e pesticidi sono i figli dei gas tossici e degli esplosivi sviluppati ed usati fin dalla guerra nel Vietnam.
Già alla fine della seconda guerra mondiale il governo americano si ritrovò con enormi quantità di nitrato di ammonio, che è alla base dell’industria degli esplosivi, ma che è anche un ottimo fertilizzante, una fonte di azoto pronta per le piante commestibili, che da ora potranno essere coltivate in maniera intensiva. E’ interessante notare come i fertilizzanti ritornino alla loro “esplosiva” natura negli attentati dei movimenti neonazisti americani (una buona dose di fertilizzanti fu impiegata nell’attentato del 1995 contro l’edificio federale Alfred P. Murrah ad Oklahoma City[1]).
Il primo e decisivo contributo della chimica organica alla distruzione dell’equilibrio naturale fu data nel 1840 da von Liebig, ma un passo fondamentale fu quello compiuto da Fritz Haber che ricevette il Nobel nel 1920 “per aver migliorato gli standard dell’agricoltura e il benessere dell’umanità”. La capacità di fissare l’azoto atmosferico nel mondo naturale è, come noto, limitata, ma grazie al processo Haber-Bosch è possibile ottenere composti azotati di sintesi. Haber fu anche l’inventore del gas Zyclon-B. Come diceva ironicamente DeLillo: “una vita migliore attraverso la chimica”…
Sicuramente grazie all’arricchimento sintetico del suolo si è riusciti a produrre molto più cibo e, secondo alcune stime, “due abitanti del pianeta su cinque non sarebbero vivi oggi senza il processo Haber-Bosch”. Come sempre è la gestione della conoscenza che determina i risultati visibili, la conoscenza in sé invece possiede un valore positivo. (E non lo dico solo perché anch’io ho pubblicato su una rivista che si chiama Current Nutrition and Food Science che appartiene alla categorie di riviste che l’autore stigmatizza. La chimica è una scienza affascinante).
Nella sua analisi dell’industria alimentare Pollan si scontra con la verità che sta alla base dell’intero processo: il mais (la monocoltura che ha radicalmente trasformato il paesaggio del Midwest americano) si trova praticamente ovunque: “un supermercato americano ha in vendita quarantacinquemila prodotti; più di un quarto di questi contiene mais, ivi inclusi articoli non alimentari”. E l’uomo? L’uomo ormai è “una pannocchia con le gambe”.
Nell’allevamento intensivo moderno viene usato il mais come elemento principale della dieta dei bovini, che per loro natura sarebbero degli erbivori; ricordate un’immagine di una mandria di bovini su un pascolo? Bene, dimenticatela. Oggi si è riusciti a convertire un ruminante in una macchina che trasforma mais in carne, ovviamente sono animali più esposti alle malattie, ma non c’è problema: l’industria farmaceutica sosterrà queste macchine fino al momento di macellarle grazie ai suoi potenti antibiotici ad ampio spettro.
“Il granturco ha il vantaggio di essere una fonte calorica concentrata che fa ingrassare le bestie in fretta e rende la loro carne marezzata al punto giusto, dotata di quel gusto e quella consistenza che i consumatori americani si sono abituati a gradire. Eppure è certo che queste bistecche di manzo tirato su a granturco (corn-fed) sono peggio per la nostra salute, perché contengono più acidi grassi insaturi e meno omega-3 rispetto a quelle di animali che si sono nutriti di erba”.
Va sottolineato che l’industria alimentare brucia un quinto del petrolio consumato negli Stati Uniti (ovvero quasi quanto tutte le automobili del paese). Questo si traduce nella devastante constatazione che sono necessarie “dalle sette alle dieci calorie di combustibile fossile per produrre ogni singola caloria che finisce sulle tavole americane”.
Michael Pollan si sposta nella parte centrale del suo saggio ad analizzare la catena alimentare biologica. Il movimento biologico nacque dalle idee di filosofi ed agronomi rivitalizzate dal movimento culturale nato alla fine degli anni sessanta. Il risultato sono un mucchio di dollari. Infatti i pionieri del settore siedono su comode poltrone all’interno del consiglio di amministrazione di aziende dal fatturato in stabile crescita. Come molti altri ex rivoluzionari in erba degli anni della contestazione hanno capito da tempo, anche per i signori del biologico “è il mercato che decide”.
E se abdichiamo dalle nostre scelte morali o riusciamo a convincerci che in fondo stiamo comunque facendo meno danni di quelli provocati attraverso l’industria alimentare standard, il mercato biologico offre un’alternativa valida. Catene di negozi come Whole Foods procurano al cliente un’esperienza culturale, che l’autore definisce “Arcadia da supermercato”. Opuscoli con verdi pascoli e fattorie, aie dove le galline razzolano libere. Ma sarà davvero così?
Indovinate.
Per essere certificato come biologico un allevamento di galline o polli deve fornire uno spazio minimo agli animali e garantire un accesso all’aperto e fornire agli animali un’alimentazione vegetale priva di pesticidi. In conclusione, Pollan entra in un capannone dove ondeggia un mare bianco di piume, migliaia e migliaia di galline, munito di una piccola porta che conduce all’esterno: peccato che le galline siano troppo timorose per avventurarsi oltre quell’apertura ed in pratica vivano sempre confinate nel loro spazio microscopico dove un sistema di pompe e canaline permette di ingozzarle di mangime ed acqua. Il biologico è servito.
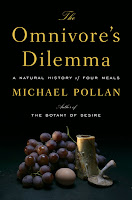
“All’inizio alcuni agricoltori riuscirono in modo ammirevole a creare nuove catene alimentari nelle loro fattorie. I guai iniziarono quando questi si scontrarono con le pretese dei supermercati. Così come è accaduto in molti altri ambiti la logica naturale non ha resistito alla forza di quella industriale in cui si dà per assunto di base che una fonte di energia a buon mercato sarà sempre disponibile” L’industria alimentare biologica si trova perciò in una posizione alquanto scomoda: “galleggia su un mare di petrolio che si fa sempre meno profondo”.
Michael Pollan è un ottimo scrittore ed alterna vivide descrizioni a riflessioni altrettanto incisive. Oltrepassata la metà del libro, entriamo in un mondo diverso, dove la catena alimentare si fa più breve. Pollan descrive una settimana passata a lavorare presso la Polyface, una fattoria della Virginia. Joel Salatin gestisce la sua azienda alternando colture diverse sui campi e spostando frequentemente gli animali, ovvero bovini, maiali, e polli e galline. Tutti si nutrono pascolando sui prati. L’erba converte l’energia solare in calorie. L’impiego di combustibili fossili è limitato all’indispensabile. Tutti i prodotti della fattoria sono venduti in un raggio di centocinquanta o duecento chilometri. Gli acquirenti sono ristoranti, consumatori individuali che si recano alla fattoria o gruppi di acquisto (un fenomeno che si sta diffondendo anche in Italia, un gruppo di persone che sceglie di fare degli acquisti congiunti per spendere meno ed avere una migliore qualità). Il risultato di questa esperienza è una cena consumata con amici dove tutto ha un sapore migliore, in fondo quello che è buono per il gusto e la mente, è buono anche per il nostro corpo: una verità che risponde al dilemma dell’onnivoro ovvero “cosa è buono da mangiare?”
Nell’ultima parte del libro Pollan affronta la catena alimentare più breve: quella del cacciatore, coltivatore e raccoglitore. Naturalmente l’autore, che nella fattoria di Joel Salatin ha partecipato all’uccisione di alcuni polli, si pone il problema del vegetarianesimo. Pollan inizia a leggere “Liberazione animale” di Peter Singer al ristorante The Palm davanti a una costata al sangue: un’esperienza che non consiglierebbe a nessuno…
L’evoluzione ci ha portato a cibarci di numerose specie rese domestiche, che senza l’uomo non vivrebbero in natura, specie per cui gli animalisti in effetti non nutrono troppa simpatia. Per un animalista l’estinzione dei polli è preferibile alla loro esistenza come prigionieri in un campo di allevamento intensivo. Ma Michael Pollan è stato alla Polyface e sa che l’allevamento non significa necessariamente sofferenza.
Non si può dire lo stesso del mondo naturale: “se un orso mette le grinfie su una pecora che allatta, se la sbrana viva, cominciando dalle mammelle. No, in genere gli abitanti del bosco non muoiono senza sofferenze circondati dall’affetto dei loro cari”.
La nostra evoluzione ci ha resi ciò che siamo: “Dovremmo perlomeno riconoscere che il nostro desiderio di mangiare carne non è, come pensano gli animalisti, una semplice predilezione gastronomica. Con lo stesso ragionamento potremmo definire il sesso, che oggi non è più strettamente necessario alla riproduzione, solo una preferenza nel modo di divertirsi. No, essere carnivori è qualcosa di molto più profondo”.
Inoltre, nella catena alimentare che ha plasmato il mondo, l’allevamento, e non parlo di allevamento industriale, ha svolto un’azione fondamentale. E’ altamente improbabile riuscire a costruire un’agricoltura sostenibile senza la presenza di animali, che mettono in circolo sostanze nutritive e tengono in piedi la produzione locale. “Se ci preoccupiamo per la salute della natura, più della coerenza delle nostre scelte etiche e dello stato della nostra anima, mangiare carne potrebbe essere quanto di più morale possibile”.
L’ultimo pasto descritto da Pollan comprende prodotti provenienti dal suo orto, prodotti raccolti, ovvero alcuni funghi e delle ciliegie, e infine un maiale selvatico cacciato nei boschi.
La catena più breve e insieme quella più faticosa. Naturalmente la caccia è l’attività che suscita in Pollan i sentimenti più contrastanti e che lo spinge alle riflessioni più approfondite. Spaziando da Emerson a Ortega y Gasset ad Aldo Leopold gli argomenti si intrecciano e si rincorrono per molte pagine.
“Confesso che una parte di me invidia la saldezza morale del vegetariano, l’innocenza del mangiatore di tofu; eppure una parte di me ne provava compassione. L’utopia dell’innocenza dipende di solito dalla negazione del vero che è anche una forma di presunzione. Secondo Ortega è in un certo senso immorale non riuscire a guardare in faccia la realtà”.
La grande bellezza della scrittura di Michael Pollan è quella di riuscire ad elaborare dell'ottimo cibo per la mente con una sapore favoloso. Ed è ciò che ogni scrittore di saggistica in fondo dovrebbe fare. Genera idee, stimola il pensiero, ispira la creatività: “Il dilemma dell’onnivoro” è tra il miglior cibo per la mente che potete trovare in circolazione.
[1] Per l’interessante rapporto tra agricoltura e movimenti neonazisti o antigovernativi americani si veda l’eccezionale saggio di Joel Dyer “Raccolti di rabbia” (Fazi, 2002).
domenica 6 luglio 2008
La casa degli incontri

Valutazione oggettiva: ottimo libro. Valutazione soggettiva: tutte le corde non me le ha toccate, qualcosa non mi ha raggiunto.
Mi rendo conto però che ci sto ancora ripensando, che mi ritrovo a ricordare il vecchio protagonista, a scuotere la testa ricordando la sua cattiveria, insana, rozza, e la sua intelligenza, e i suoi momenti di pura dolcezza.
Forse questo scioglie ogni dubbio.
Amis è inglese. Uno dei più grandi autori inglesi. Come molti mi chiedo quanta bravura serva per riuscire a farti entrare così nelle viscere di un popolo senza appartenervi.
La Russia.
I gulag.
Il terrore. La noia.
Amis riesce davvero a trasportarci su di un treno che corre tra passato e presente, in una lunga conversazione con chi ancora non sta ascoltando. Riesce a farci sentire la rabbia, l'assoluta mancanza di redenzione, il sapore crudo e fastidioso della prigionia, di un limite da oltrepassare.
Riesce a trovare posto all'emozione, alla storia, ai legami, ai ricordi, il tutto in poco più di 200 pagine che sembrano il doppio per la densità delle parole.
Due fratelli, due vite, una prigionia, molte volontà, frammenti di guerra, e dolore, e cattiveria.
Molte donne, un solo amore, totalizzante, dannoso, furente.
La casa degli incontri è si il titolo del libro, il suo punto focale, un luogo nel quale si decide un Destino, ma non è che il centro di un panorama molto più grande, il simbolo di una scelta e di una perdita.
Il luogo in cui i prigionieri del campo potevano fingere, per una notte, di essere uomini normali. Il luogo al quale giungevano le mogli, una sola notte per settimane di viaggio, una sola notte per ritrovare negli occhi di un individuo perduto lo sguardo di chi con te condivide tutto.
Il nucleo ruota intorno ai due fratelli, perché solo uno di loro entrerà in quella Casa, e facendolo darà il via a dinamiche che verranno capite solo nelle ultimissime pagine del libro.
Amis ci regala un protagonista che si definisce, conversando con la figlia, "vecchio sporcaccione", "stupratore", "uomo perduto".
Non fa niente per redimersi, niente per chiedere perdono, niente per avere seconde occasioni.
In questo sta l'onestà del suo essere una creatura rabbiosa, perduta, ma in fondo umana.
Questo vecchio, che viaggia su un treno che lo riporta al punto di origine, non sta chiedendo nulla. Racconta. Ricorda. Espone i fatti a volte in modo quasi chirurgico.
Ricorda la guerra, la prigionia, gli stupri, le scelte.
Ci parla di un paese facendocelo sentire sotto la lingua, come un sapore acido di cui non riesci a liberarti.
E in questo modo ci cattura, non lasciandoci più fino alla fine della corsa.
sabato 5 luglio 2008
Sigur Ros: Með suð í eyrum við spilum endalaust
 L'ultimo lavoro dei Sigur Ros ha un suono nuovo, più aperto. E' possibile capire l'aria che tira già dal titolo che compare, anche in inglese, sulla copertina: With a buzz in our ears we play endlessly. Le canzoni hanno echi di sensazioni confuse, illuminate per brevi istanti da lampi improvvisi. Ma più spesso in Með suð í eyrum við spilum endalaust, il ritmo ricorda quello ampio di una lunga ballata che si fa strada nel caos per emergere dopo una corsa a perdifiato tra archi e percussioni.
L'ultimo lavoro dei Sigur Ros ha un suono nuovo, più aperto. E' possibile capire l'aria che tira già dal titolo che compare, anche in inglese, sulla copertina: With a buzz in our ears we play endlessly. Le canzoni hanno echi di sensazioni confuse, illuminate per brevi istanti da lampi improvvisi. Ma più spesso in Með suð í eyrum við spilum endalaust, il ritmo ricorda quello ampio di una lunga ballata che si fa strada nel caos per emergere dopo una corsa a perdifiato tra archi e percussioni.Il singolo Gobbledigook non rende sicuramente giustizia a questo album: Með suð í eyrum (With a buzz in our ears), la sesta traccia, è più rappresentativa, il pianoforte inizia una lenta marcia per lasciarsi accompagnare dalla voce, ritmata dalle percussioni, e dai cori che sono un respiro continuo dietro la melodia. Per contro la quarta traccia, Við spilum endalaust (We play endlessly), si apre mettendo in risalto le percussioni per arrivare sulla cima di un suono, sempre in precario equilibrio verso qualcosa di diverso. Tutto l'album trasmette questa sensazione di una s
 cala a salire verso una visione più ampia e brillante, dove colori e suoni si fondono.
cala a salire verso una visione più ampia e brillante, dove colori e suoni si fondono.Registrato a New York, Londra e a La Havana, Með suð í eyrum við spilum endalaust segna un passaggio importante nella discografia dei Sigur Ros e probabilmente porterà nuovi ascoltatori al gruppo, non è "easy listening", ma è un disco più pulito, che attrae dal primo ascolto, essere coinvolgenti non è sinonimo di "facile".
