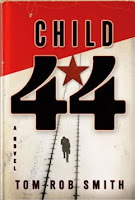Con una nuova traduzione Giano riporta in libreria “Cuori solitari” di John Harvey. Pubblicato in Inghilterra nel 1989 questo romanzo propose al pubblico Charlie Resnick, un ispettore di polizia di Nottingham. Divorziato, un po’ soprappeso, ma dotato di fascino. Vive con quattro gatti: Dizzy, Bud, Pepper e Miles. Così tanto per chiarire i suoi gusti musicali. In questa prima storia (i romanzi che lo vedono protagonista sono finora undici) il lettore entra in sintonia con Resnick. Le vite private dei personaggi compaiano davanti agli occhi in brevi frammenti. L’abito stazzonato, le scarpe pulite con cura che subito s’imbrattano di fango, il sandwich che si sbriciola sul mento, la voce di Billie Holiday che arriva dagli anni ‘50: “Era il 1954 e stava per compiere quarant’anni, ma le restava poco da vivere. Morì in un letto d’ospedale, piantonata da un poliziotto e con i soldi del prossimo buco legati alla gamba malata.
But I don’t stand
A ghost of a chance with you”.
Questo è Resnick. Questo e molto altro ancora.
E’ inverno a Nottingham. L’amore cercato nelle inserzioni per cuori solitari può portare a strane conoscenze. Una donna assassinata. Un ex fidanzato violento. Tracce semplici e percorsi più oscuri. L’importanza della trama è in secondo piano. Già nei racconti di Conan Doyle alla fine il lettore scorgeva nelle geniali deduzioni di Holmes quello che in realtà erano, ovvero felici e brillanti intuizioni. La maschera dell’enigma aveva ceduto il posto al detective. Il carisma del personaggio ha decretato la fama di Sherlock Holmes. Ed è il fascino dei personaggi, le loro vite ciò che rende unici i romanzi di John Harvey o di Ian Rankin. Aspettiamo ancora Resnick e la penna di Harvey, il gesto lieve dello scrittore che sembra scomparire lasciando spazio alla storia e ai suoi protagonisti